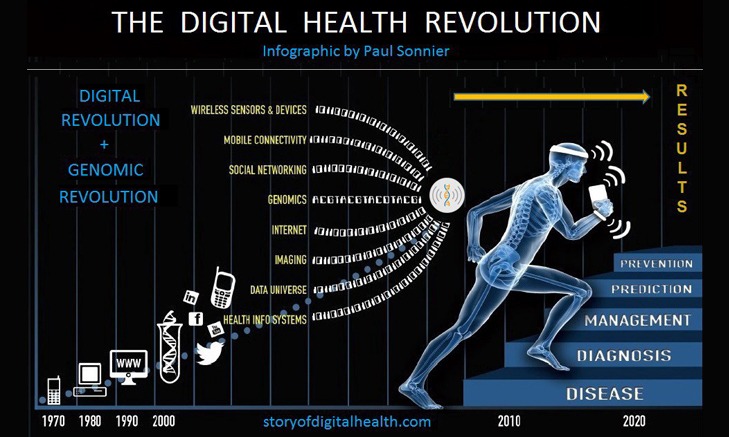Ecco come le biotecnologie e l’ingegneria genetica ispirano gli sceneggiatori
Dal Doctor Who a The Walking Dead, le più recenti scoperte e applicazioni delle biotecnologie hanno colpito l’immaginario degli sceneggiatori delle serie TV. È così che uno degli strumenti narrativi più potenti dei nostri tempi è riuscito a coinvolgere il grande pubblico nella cultura scientifica. Ma il confine tra scienza e fantascienza è davvero così netto?
Le serie TV oggi sono uno degli strumenti narrativi più efficaci e seguiti: il loro punto di forza è la capacità di unire la potenza del racconto cinematografico e la componente della serialità, che permette di diluire la trama in tempi più lunghi e di fare leva sull’elemento dell’attesa.
Dal canto suo, la scienza è da sempre anche un grandioso meccanismo narrativo, capace di creare trame, offrire spunti, costruire personaggi. Dalle scienze forensi descritte nei racconti di Edgar Allan Poe e nelle avventure di Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle, alle tecnologie immaginate nei romanzi di Isaac Asimov e di H.G. Wells.
Era inevitabile che alcune delle serie più seguite avessero come protagonista una delle frontiere avanzate della ricerca scientifica come le biotecnologie e l’ingegneria genetica, cioè tutte quelle tecnologie che si servono dei sistemi biologici (cellule, batteri, virus) e li modificano, con ampie applicazioni nella medicina, nell’agricoltura e nell’industria.
Ma fino a che punto le fiction sono attendibili dal punto di vista scientifico?
Se non si può certamente parlare di divulgazione di conoscenze scientifiche nelle fiction, le serie si fanno apprezzare anche come strumento per coinvolgere il grande pubblico nella cultura scientifica.
Inoltre, a differenza dei documentari, la descrizione della scienza nelle serie è inserita all’interno del suo contesto sociale e il pubblico a cui si rivolgono è molto più vasto e differenziato, non sempre sensibilizzato ai temi scientifici. Rispetto ai documentari le fiction coinvolgono emotivamente lo spettatore.
Certo, questo a volte accade a discapito dell’appropriatezza delle informazioni e di una chiara definizione di cos’è o cosa non è la scienza, che invece troviamo proprio nei documentari: le imprecisioni scientifiche che i creatori delle serie TV inseriscono nella trama delle loro creazioni sono ovviamente funzionali alla storia. È anche vero che gli sceneggiatori si affidano alla consulenza di scienziati ed esperti per raccontare la scienza nella maniera più veritiera.
Nonostante nei telefilm la fantasia abbia spesso il sopravvento sulla verità scientifica, può accadere che sia la scienza a trarre, a volte, ispirazione dalla fantascienza. In effetti molte tecnologie descritte in serie TV o romanzi del passato sono poi diventate reali o hanno raggiunto livelli di avanzamento che non avremmo immaginato qualche anno fa.
Vediamo quali sono le serie TV più recenti e conosciute che hanno come protagoniste le biotecnologie.
I Signori del Tempo e la rigenerazione tissutale: Doctor Who

Doctor Who è una serie televisiva britannica di fantascienza prodotta dalla BBC a partire dal 1963, che vanta stagioni fino agli anni più recenti (la dodicesima stagione andrà in onda nel 2020). Ha per protagonista un Signore del Tempo, cioè un alieno viaggiatore del tempo, dalle sembianze umane, che si fa chiamare semplicemente Il Dottore. Il Dottore esplora l’universo a bordo del TARDIS, una macchina senziente capace di viaggiare nello spazio e nel tempo attraverso il cosiddetto vortice del tempo.
Da un punto di vista biologico, una delle caratteristiche più particolari del Dottore è la capacità di rigenerare i tessuti.
L’extraterrestre ha infatti circa 2.000 anni di vita e ha ingannato la morte diverse volte. Gli individui della sua specie, Dominus Temporis, sono in grado di rigenerarsi molte volte nel corso della propria vita (un espediente per cambiare attori nella fiction e tenere giovane una serie che ha ormai più di 50 anni).
La rigenerazione permette loro di salvarsi da ferite mortali, trasformandoli però in individui diversi per forma fisica e personalità, poiché ogni cellula del corpo cambia.
La rigenerazione tissutale è qualcosa che avviene anche nel nostro organismo, sia pure in modo limitato, per esempio a seguito di una ferita. In natura esiste però una creatura chiamata idra, che è in grado di rigenerare il proprio corpo in soli 3-4 giorni. Si tratta di un organismo semplice, lungo da 1 a 20 mm, che vive in pozze di acqua dolce.
L’idra ha il potere della morfallassi: quando subisce un trauma e le viene asportata una parte del corpo, il tessuto rimasto è in grado di tornare al momento in cui le sue cellule non erano differenziate, per esempio in organi o pelle, e ognuna di loro può specializzarsi nuovamente per svolgere un’altra funzione e formare un nuovo tessuto. Le cellule tornano quindi alla loro condizione di cellule staminali, capaci cioè di ricreare tutti i tessuti che formano un intero organismo.
Gli studi sulle cellule staminali sono importanti proprio perché queste cellule potrebbero aiutarci a sconfiggere molte patologie degenerative.
Al Dottore della serie potrebbe succedere una cosa simile, ma ovviamente l’organismo umano è infinitamente più complesso e la rigenerazione dovrebbe riguardare anche la complicata rete di neuroni e connessioni che il cervello dell’alieno ha sviluppato nella sua lunghissima vita. Sarà per questo che nella serie il dottore cambia anche personalità per ogni rigenerazione?
Cloni e madri surrogate: Orphan black



Una serie molto recente è Orphan Black, la cui quinta stagione è stata trasmessa per la prima volta a giugno del 2017.
In questo caso l’ingegneria genetica la fa da padrona e la serie va ad esplorare il discusso tema della clonazione umana. Per prima cosa dobbiamo precisare che nessun essere umano è mai stato clonato e che questa pratica sarebbe ad ogni modo illegale, con conseguenze, sulla società e sul singolo individuo, che sono ancora lungi dall’essere del tutto chiare. Detto questo, in Orphan black è immaginato un mondo in cui la clonazione umana è possibile e lo scenario descritto è molto realistico, poiché le tecniche di clonazione descritte sono molto simili alle tecniche di fecondazione in vitro.
In biologia, per clonazione si intende il processo attraverso il quale si crea una copia biologica di un organismo: si avranno, cioè, due individui con un codice genetico identico.
Come premesso, la clonazione non è stata applicata agli umani, ma sono state clonate piante e vertebrati, fino ad arrivare ai primati non umani. In questo ultimo caso è stata usata la stessa tecnica utilizzata per clonare la pecora Dolly nel 1996 in Scozia (seppur con accorgimenti più innovativi e dovuti alla differenza di specie), cioè la tecnica chiamata somatic cell nuclear transfer (SNCT). In questo metodo il nucleo, quindi il DNA, di una cellula adulta del soggetto da clonare viene inserito in una cellula uovo di un altro soggetto; l’ovocita viene poi impiantato in una madre surrogata e l’individuo che nascerà sarà geneticamente identico al soggetto che ha donato il nucleo della cellula somatica iniziale. Quindi, per clonare un essere umano, un embrione ottenuto tramite SCNT dovrebbe essere impiantato in una madre surrogata, e seguire il normale periodo di gestazione di 9 mesi. E questo è proprio quello che succede in Orphan Black.
Il processo del SCNT è ovviamente molto complicato, l’impianto non ha sempre successo e i cloni animali ottenuti fino ad oggi hanno spesso manifestato problemi di salute e invecchiamento precoce.
Anche in Orphan Black non tutti i cloni appaiono in salute, alcuni muoiono prematuramente e altri sono affetti da malattie. Nella serie, inoltre, i cloni non sono solo copie identiche di altri individui, ma il loro genoma è stato anche in qualche modo modificato per far sì che abbiano delle caratteristiche peculiari (ad esempio, i cloni non sono fertili).
Possiamo immaginare che queste modifiche siano state fatte tramite terapia genica, che prevede l’inserimento di geni modificati nelle cellule non riproduttive del corpo. Nel caso di Orphan Black la terapia genica sarebbe però stata utilizzata per introdurre un disordine genetico, invece che curarlo.
Il genoma dei cloni potrebbe anche essere stato modificato durante il processo stesso di clonazione, oppure usando una tecnica come CRISPR/cas9, di recentissimo sviluppo, con la quale possono essere modificate delle sequenze target del DNA (è recente fa la notizia di due gemelline cinesi che sarebbero nate col DNA modificato con questa tecnica per renderle resistenti all’HIV).
Si tratta di tecnologie che però non esistevano negli anni ’70 e ’80, quando i cloni di Orphan Black sono nati, come racconta la serie.
Virus e zombie: da The Walking Dead a Z-Nation



Sono numerose le serie TV che hanno per protagonisti gli zombie o morti viventi, dal capostitpite The Walking Dead, fino a Z-Nation, I-Zombie e Santa Clarita Diet. In queste fiction gli zombie sono spesso associati alla comparsa di un microrganismo, di solito un virus, che infetta gli umani trasformandoli in morti viventi affamati di cervelli.
Per quanto strano possa sembrare, le serie sugli zombie sono apprezzate da medici e biologi perché sono un modello narrativo perfetto per descrivere i meccanismi dell’epidemiologia e rendere il pubblico più consapevole sulla diffusione delle malattie infettive.
Gli studi epidemiologici, oltre a indagare la distribuzione e la frequenza delle malattie nella popolazione, servono anche a evitare e monitorare le possibili pandemie (la diffusione di una malattia infettiva a livello planetario in un intervallo di tempo molto rapido e con numerosissimi casi).
Proprio quello che potrebbe succedere con un nuovo e sconosciuto patogeno, con elevata mortalità e capace di diffondersi facilmente trasformando le persone in morti viventi, come accade nelle serie TV.
Ad esempio, in The Walking Dead, già nella prima stagione, il dottor Edwin Jenner (che porta lo stesso nome di Edward Jenner, l’inventore dei vaccini) del Center for Disease Control and Prevention di Atlanta avanza l’ipotesi che l’epidemia zombie possa essere causata da un agente patogeno che invade il cervello.
Sappiamo che esistono dei virus, detti neurotropi, in grado di attaccare il cervello causando comportamenti aggressivi e bizzarri. Uno di questi è il virus della rabbia, che come spesso accade per l’immaginario virus zombie, si trasmette tramite il morso e induce le persone a comportamenti aggressivi.
Pensando ai virus, un modo in cui potrebbe svilupparsi una fantomatica epidemia zombie è tramite la fusione di due virus diversi in un ibrido.
È un fenomeno legato alla natura stessa di questi microorganismi, che, quando si trovano ad infettare una stessa cellula, possono scambiarsi materiale genetico. Questo fenomeno ha probabilmente portato, ad esempio, alla nascita del virus dell’HIV umano.
Inoltre, i virus mutano molto velocemente, e anche questa capacità potrebbe, nell’immaginario, portare allo sviluppo di ceppi di virus zombie.
In Io sono leggenda (non è una serie TV, ma un libro da cui sono stati tratti anche dei film), un virus del morbillo geneticamente modificato per ottenere un vaccino per il cancro, causa una pandemia e la trasformazione dei sopravvissuti in creature rabbiose sensibili alla luce del sole, simili agli zombie.
In questo caso, quindi, il virus zombie è stato creato proprio tramite le biotecnologie. Comunque sia andata nelle serie TV, in alcuni centri medici degli Stati Uniti sono state eseguite simulazioni per affrontare un’apocalisse zombie e i centri di controllo delle malattie hanno una guida per prepararsi all’eventualità, che viene usata come esempio per qualunque tipo di catastrofe naturale o emergenza. È la conferma di come al di là della finzione narrativa, le serie TV possano divulgare conoscenze scientifiche e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla trasmissione delle malattie.
Vampiri e sangue sintetico: True Blood
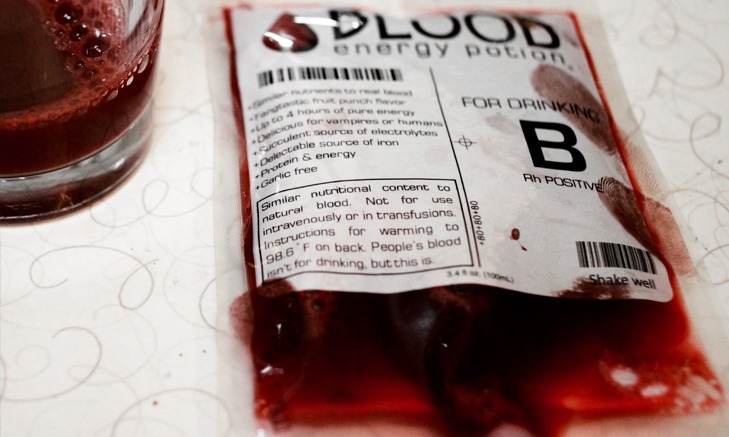
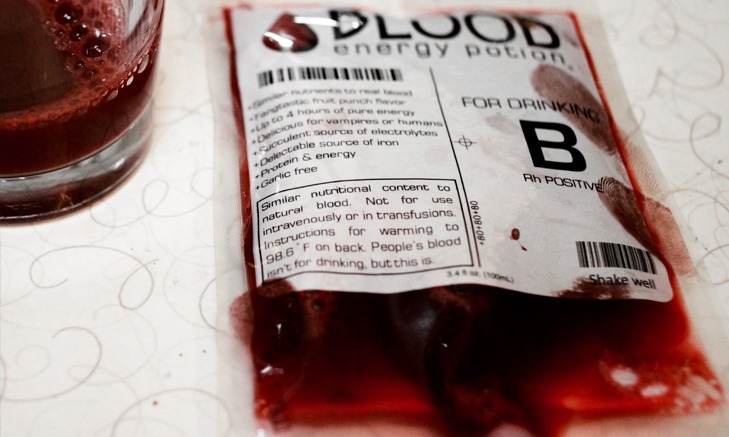
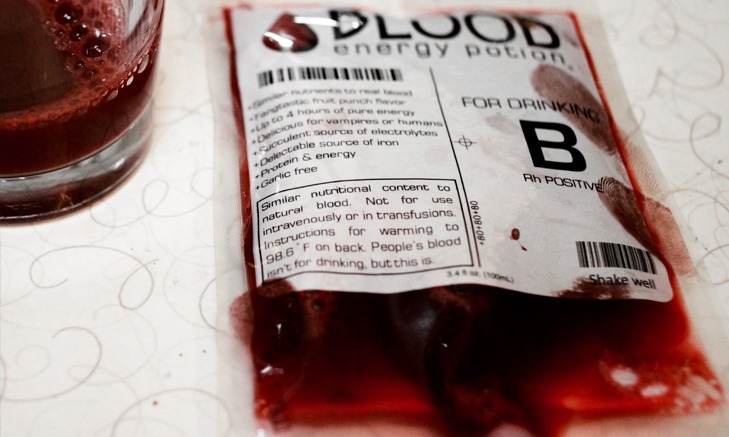
True Blood è una serie che conta sette stagioni, andata in onda in Italia fino al 2014.
In questo telefilm un’azienda farmaceutica giapponese inizia a produrre sangue sintetico per soddisfare le esigenze alimentari dei vampiri, che quindi possono uscire allo scoperto e tentare di convivere con gli umani.
Il True Blood del telefilm è disponibile in vari gusti e gruppi sanguigni e costa sui 45 dollari a bottiglia. Viene ovviamente servito caldo, intorno ai 37 gradi.
La creazione di sangue sintetico è un obiettivo realmente perseguito dagli scienziati, poiché risolverebbe il problema della disponibilità di sangue per le trasfusioni. Un replicato sintetico perfetto del sangue reale è in realtà molto complesso da ricreare in laboratorio, viste le caratteristiche molecolari che hanno i globuli rossi dei diversi gruppi sanguigni (le stesse che rendono i donatori compatibili solo con persone con lo stesso gruppo sanguigno).
Per questo, la ricerca si concentra al momento sulla creazione di un sostituto del sangue che possa svolgere la sua funzione principale: trasportare ossigeno nell’organismo.
Da una parte si cerca di perseguire questo fine studiando molecole in grado di legare l’ossigeno e dall’altra di sfruttare il sangue animale o tentando di riprodurre i globuli rossi artificialmente, partendo da cellule staminali del sangue.
Nel Regno Unito nel 2017, per la prima volta, è stato creato un sangue artificiale, producendo in laboratorio globuli rossi a partire da cellule staminali. Dopo una serie di tentativi falliti, la strada imboccata sembra essere quella giusta, anche se al momento i donatori restano indispensabili.
Roberta Altobelli
Copywriter rubata alla biologia, dopo tanti anni in laboratorio e un Master in Genetica Forense decide di dedicarsi alla scrittura e da un anno lavora in ProFormat Comunicazione.
Nel 2015 ha conseguito un Master in Comunicazione della Scienza e da allora ha collaborato con blog, testate e agenzie di comunicazione.
Fonti:
• Exploring the Referral and Usage of Science Fiction in HCI Literature Philipp Jordan, Omar Mubin, Mohammad Obaid, Paula Alexandra Silva, 2018
• The real science of science fiction, Susan Stepney, The Guardian, 2015
• L’Effetto CSI: stereotipi nella divulgazione delle scienze forensi nelle crime fiction, Roberta Altobelli, 2015
• La scienza delle serie tv, Andrea Gentile, Codice Edizioni, 2016